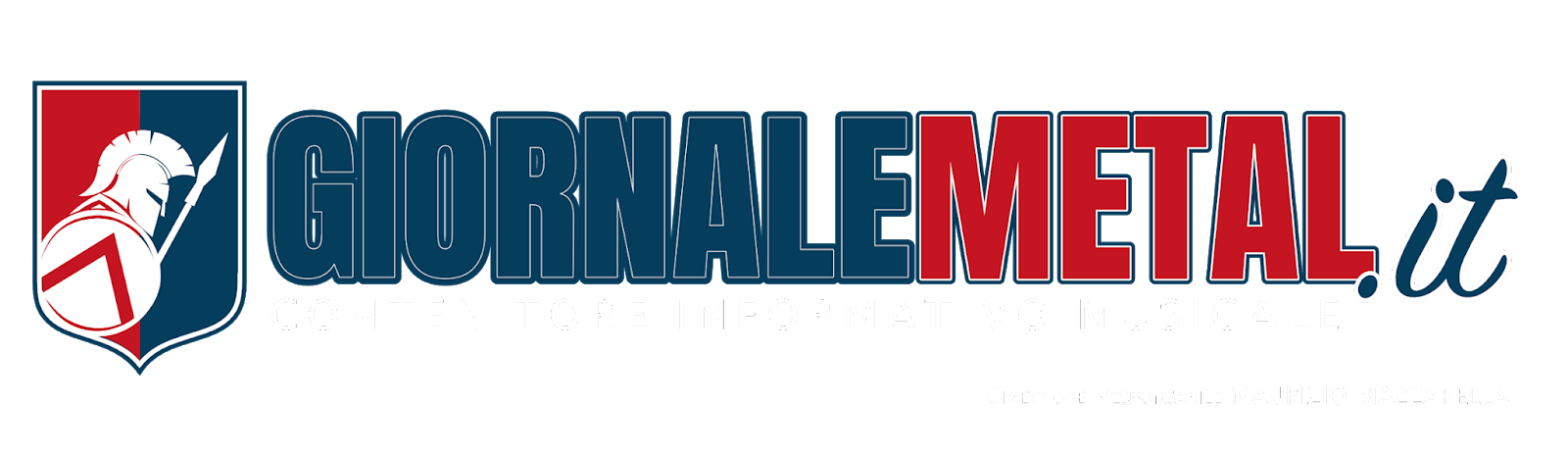ArcelorMittal aveva due strade: conquistare l’Ilva di Taranto oppure distruggerla. Ha scelto la seconda. Anche il governo italiano aveva due strade: vendere il centro siderurgico di Taranto a un nuovo imprenditore privato sperando di prolungarne la vita oltre i suoi quasi sessant’anni, oppure programmare un futuro diverso per questo pezzo di Mezzogiorno. Avrebbe dovuto ovviamente costruire un diverso modello di sviluppo. Servivano idee. Così ha scelto la prima strada e consegnato la più grande azienda siderurgica italiana a chi ora minaccia di chiuderla. Un colpo da maestro.
Comunque finisca, ArcelorMittal otterrà un risultato importante: eliminato un concorrente, ne intascherà i clienti, rafforzerà il suo primato di principale produttore mondiale di acciaio. Invece lo Stato italiano si ritroverà tra le mani un disastro. Se la fabbrica chiude, il governo Conte incasserà l’esatto contrario di quel che voleva: non avrà l’acciaio così indispensabile all’industria italiana, rinuncerà a 1,4 punti di Pil e dovrà fare fronte a una drammatica emergenza, 10.700 metalmeccanici senza lavoro (8.200 a Taranto) e, solo in Puglia, un indotto da 5.000 unità tramortito dall’assenza di alternative alla siderurgia. Senza contare i costi per affrontare la bonifica di Taranto, ammesso che si farà. C’è una terza strada, in teoria: un accordo tra le parti, benché sembri ogni giorno più improbabile. Ovviamente vedrebbe ArcelorMittal in una posizione di forza e l’Italia costretta a una resa pressoché assoluta. Dopotutto, chi potrebbe gestire le acciaierie di Taranto? E dov’è l’alternativa industriale? Perciò, se non lascia Taranto, ArcelorMittal darà le carte: taglierà, ridimensionerà, insomma farà quello che gli pare. Non sarebbe la prima volta.
Era difficile realizzare un simile capolavoro, ma cinque governi di fila hanno deciso di risolvere il problema dell’acciaio (quindi anche il problema inquinamento dovuto alla produzione di acciaio) semplicemente rinviandolo, cioè trasferendo un bel carico di dinamite al governo successivo, come se la dinamite non dovesse mai esplodere. Abbiamo visto il risultato. Siamo all’ultimo atto di questa pazzesca roulette russa. La famiglia Mittal è fatta così. Fa affari e adotta pratiche sbrigative. Nel 2006 ingoiò la francese Arcelor scalandola in Borsa con una offerta pubblica di acquisto, nel 2013 ci mise un nulla, in Lorena, a chiudere l’area a caldo dello stabilimento di Florange attirandosi le critiche feroci della politica. Dal governo Hollande arrivarono attacchi per “il non rispetto per gli impegni, i ricatti e le minacce”, più o meno le stesse parole che ascoltiamo in questi giorni dal governo italiano. Poi, ad area a caldo chiusa, si trovò un accordo. Certo Florange era un affare da un migliaio di posti di lavoro. Taranto è cosa diversa. Emilio Riva, quando vi arrivò nel 1995, mise in chiaro, come primo proprietario privato dell’azienda, che la fabbrica aveva un senso con questo layout, cioè con questa conformazione: ciclo integrale, area a caldo, altiforni. Non a caso nel 2005, per motivi sanitari (troppi morti per tumore), fu chiusa l’area a caldo di Genova Cornigliano, ma potenziata quella tarantina, dieci volte più grande. A Taranto fu permesso ciò che in Liguria era vietato. Le cose sarebbero cambiate nel 2012, data di avvio dell’inchiesta giudiziaria per disastro ambientale che disarcionò Riva, se più governi in successione non avessero prodotto i famosi 12 decreti salva-Ilva. Non hanno risolto il problema, come si vede. Siamo fermi sempre sulla stessa mattonella. Però la famiglia Mittal sta spegnendo la fabbrica. Ha capito in ritardo che gestire le acciaierie di Taranto è un suicidio e preferisce sloggiare? Vuole mettere il governo con le spalle al muro? Non fa differenza. In ogni caso vincerà, in ogni caso si porterà a casa i clienti dell’Ilva, sia che resti a governarla, sia che la neutralizzi andando.
Questa è, ovviamente, la fine del discorso. Ma l’errore è probabilmente alla radice. E’ bizzarra l’idea di conservare intatto uno stabilimento siderurgico nato negli anni Sessanta su un modello sostanzialmente ottocentesco, cioè un’azienda grande 15 chilometri quadrati, attaccata alla città con le sue duecento e passa ciminiere, basata sul ciclo integrale in un Paese privo di materie prime. Risulta singolare perfino a un occhio inesperto, purtroppo non a governi che dovrebbero avere lo sguardo lungo e ce l’hanno solitamente cortissimo, diciamo fino alla prossima campagna elettorale.
Una fabbrica-città come l’Ilva sarebbe difficile da progettare oggi e poteva realizzarla solo, nel secondo dopoguerra, la portentosa macchina delle Partecipazioni Statali. Antonio Gozzi, ex presidente di Federacciai, ha ricordato in una trasmissione radiofonica qualche giorno fa che il management delle vecchie Partecipazioni Statali era di prima qualità e ha servito la causa siderurgica in giro per l’Europa anche dopo la fine dell’Iri. La sua onesta dichiarazione rende merito a una classe di supertecnici rottamata dalle privatizzazioni e fa venire in mente un’affermazione datata 2012. Disse Sergio Noce parlando dell’Ilva di Taranto: «I costi energetici sono enormi, in Italia non abbiamo le materie prime e ne servono trenta tonnellate per produrre una tonnellata di acciaio. Uno stabilimento così si potrebbe costruire lontanissimo dalla città, ma non lo farei in Italia. Ma no, non lo farei neppure all’estero». Noce è stato un manager delle Partecipazioni Statali, dirigente dell’Italsider di Taranto negli anni Settanta e storico direttore dello stabilimento nei primi anni Ottanta. Nessuno potrebbe irreggimentarlo in una delle categorie in cui continuiamo a dividerci da anni. Buoni e cattivi, ambientalisti e industrialisti, difensori della salute e tutori del lavoro, più i soliti formidabili “illuministi” capaci di dare lezioni a chiunque. Guardiamoci intorno, ecco come siamo ridotti. La domanda atroce ora è questa: come può una classe politica che ha combinato questo disastro riuscire a risolverlo? Purtroppo il peggio deve ancora venire.
Tonio Attino